La Simpatia per Adam Smith: La Teoria dei Sentimenti Morali spiegata
Pubblicato: 30/10/2025
Ultima modifica: 28/12/2025
Pubblicato: 30/10/2025
Ultima modifica: 28/12/2025
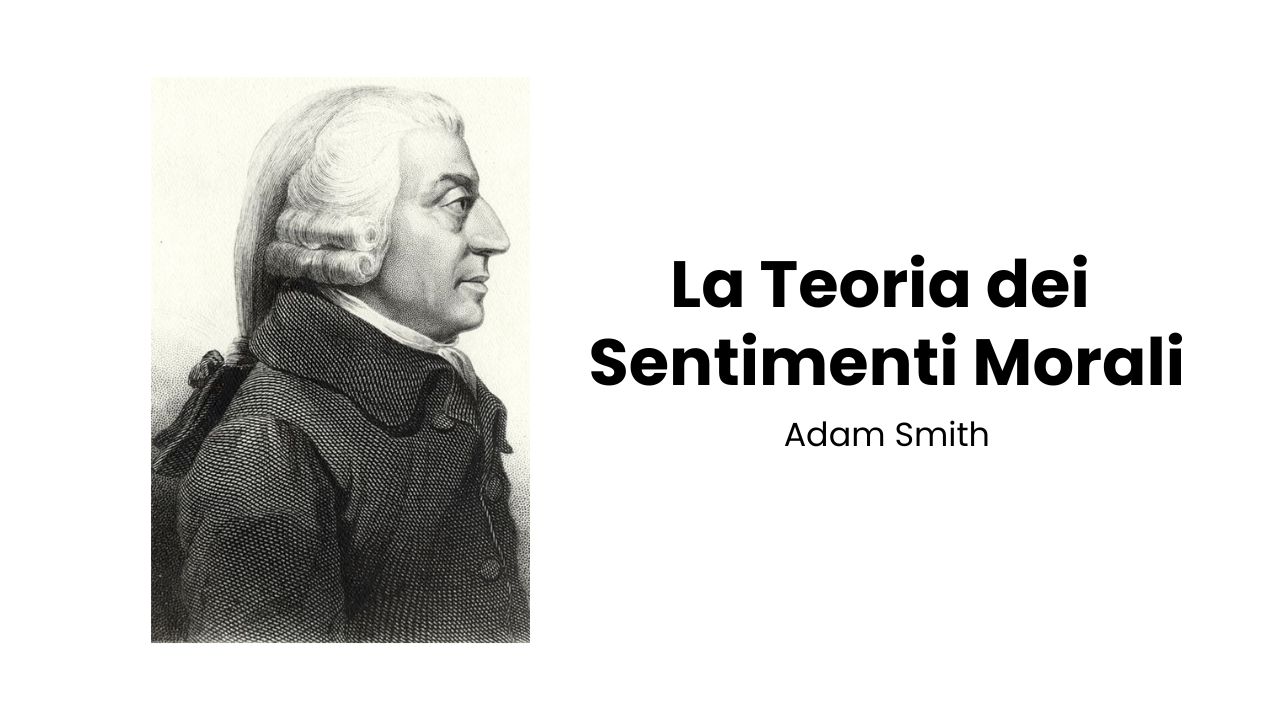
Quando pensiamo ad Adam Smith, ci viene subito in mente La ricchezza delle nazioni e la nascita dell’economia moderna. Eppure, molto prima di scrivere di mercati e lavoro, Smith si era occupato di qualcosa di più profondo: le emozioni che ci legano gli uni agli altri. Nella Teoria dei sentimenti morali (1759), Smith indaga ciò che rende possibile la convivenza umana e la moralità: non la ragione fredda, ma una facoltà più immediata e sottile, la simpatia.
Per Smith, l’essere umano non è un individuo isolato e spinto solo dal proprio interesse. Anche l’individuo più egoista, dice, non può restare indifferente davanti alla sofferenza o alla gioia altrui. In noi agisce una forza immaginativa che ci permette di “metterci nei panni degli altri”, di sentire per e con loro. È questa capacità di partecipazione emotiva che fonda il nostro senso morale, la nostra idea di giusto e sbagliato, la nostra ricerca di approvazione e armonia nelle relazioni.
In un’epoca che tende a contrapporre razionalità ed emozione, l’intuizione di Smith conserva un fascino sorprendentemente attuale: la moralità nasce dall’empatia, e la società si regge su una rete di emozioni condivise, continuamente bilanciate dallo sguardo reciproco.
L’uomo, per quanto egoista, presenta dei principi che lo rendono partecipe delle fortune o sventure altrui, nonostante non tragga da esse nessun beneficio diretto. Uno di questi principi è la compassione (o pietà), ovvero l’emozione che proviamo per la miseria altrui. Alla vista di un uomo che soffre, soffriamo anche noi, e questo è un dato di fatto. Non è nemmeno necessario essere estremamente virtuosi per provarlo, chiunque di noi prova questa sensazione. Smith infatti dice:
Nemmeno il più gran furfante, il più incallito trasgressore delle leggi della società ne è del tutto privo.
Però, se qualcun altro sta soffrendo, come facciamo a conoscere i suoi dolori? Non abbiamo esperienza diretta di ciò che prova, quindi non possiamo conoscerli. Perciò l’unico modo è immedesimarci nel sofferente, come se fossimo noi a patire le sue pene, e quello che proviamo alla sua vista, è quello che ci immaginiamo proveremmo se fossimo lui. È solo attraverso l’immaginazione che noi possiamo concepire quali siano le sue sensazioni.
A questo punto Adam Smith per dimostrare ulteriormente la sua teoria propone degli esempi concreti:
Quando vediamo che la gamba o il braccio di un’altra persona stanno per ricevere un colpo, istintivamente ci contraiamo e ritiriamo la nostra gamba o il nostro braccio, e quando il colpo cade, in una certa misura lo sentiamo anche noi, e ne siamo feriti quanto la vittima.
La simpatia dunque è la parola usata per indicare il nostro sentimento di partecipazione per qualunque passione, bella o brutta.
La simpatia però non nasce automaticamente da ogni emozione, ma dipende dalla possibilità di condividere interiormente la prospettiva di chi la prova. Quando vediamo qualcuno furioso, prima ancora di sapere perché lo sia, tendiamo a disapprovarlo e a parteggiare per chi subisce la sua rabbia, perché è più facile immaginare la paura o il disagio della vittima che immedesimarsi nella rabbia dell’aggressore.
Smith osserva anche che la simpatia è incompleta finché non conosciamo la causa delle emozioni altrui. Davanti a una sofferenza non spiegata, proviamo solo una vaga inquietudine e curiosità: vogliamo sapere che cosa è successo. Solo quando comprendiamo la situazione concreta dell’altro, la nostra partecipazione diventa autentica e profonda. Non reagiamo tanto alla passione che vediamo, quanto a quella che immaginiamo proveremmo noi nella stessa condizione. Per questo possiamo, ad esempio, provare vergogna al posto di chi non ne prova affatto: l’immaginazione ci fa sentire imbarazzo per lui, anche se egli rimane del tutto inconsapevole della propria inadeguatezza.
Secondo Smith la condizione peggiore per un essere umano è la perdita della ragione, nonostante chi ne soffre, spesso non si rende neanche conto della situazione nella quale si trova. Il vecchio malato scherza e ride, ma solo perché non è conscio della sua condizione. Ma per noi che osserviamo dall’esterno e ci immedesimiamo in lui, pur conservando la nostra lucidità, è terribile.
L’autore spiega che provare simpatia per i defunti è un’illusione dell’immaginazione: attribuiamo loro sentimenti che in realtà non possono più provare. Ci commuoviamo pensando alla perdita della luce, della vita e dell’affetto dei vivi, ma queste sono sofferenze che noi immagineremmo di sentire, non che i morti sentono davvero.
Ricevi le notifiche in tempo reale e partecipa alle discussioni nel nostro gruppo dedicato su Telegram.
💬 Unisciti al Canale →A prescindere dalle cause della simpatia, non c’è nulla che ci faccia più piacere dell’osservare la completa partecipazione altrui a tutte le nostre emozioni.
Un uomo è mortificato quando, dopo essersi sforzato di divertire la compagnia, si guarda intorno e vede che nessuno tranne lui ride alle sue battute. Al contrario, il divertimento della compagnia è per lui estremamente piacevole, ed egli considera come il più grande degli elogi questa corrispondenza dei loro sentimenti con i suoi.
Quando leggiamo un libro con qualcuno, ad esempio, proviamo piacere nel vedere che l’altro si diverte perché la sua emozione rinnova la nostra, anche se l’opera per noi non è più nuova.
Tuttavia, questo non basta a spiegare l’intero fenomeno: la corrispondenza dei sentimenti altrui con i nostri è di per sé una fonte di piacere o dolore. La simpatia degli amici ravviva la gioia perché aggiunge una nuova fonte di soddisfazione, ma allevia la pena perché introduce, nel cuore afflitto, l’unica sensazione piacevole ancora possibile: quella di non esseresoli nel proprio dolore.
Il bisogno di essere compresi è più intenso nel dolore che nella felicità, per questo siamo più ansiosi di comunicare più volentieri ai nostri amici le emozioni dolorose rispetto a quelle gioiose. Cerchiamo con più urgenza la simpatia altrui nella sofferenza, perché essa ci offre sollievo e conforto. Al contrario, ignorare o minimizzare il dolore altrui è una delle offese più gravi: se la mancanza di partecipazione alla gioia è semplice insensibilità, l’indifferenza di fronte alla sofferenza è vera inumanità.
Quando ascoltiamo qualcuno lamentarsi con grande intensità delle proprie sventure, spesso ci impressiona il dolore che esprime. Ma se ci rendiamo conto che le stesse difficoltà, se capitassero a noi, non ci colpirebbero così profondamente, tendiamo a considerarlo debole o eccessivamente sensibile. Allo stesso modo, vedere qualcuno esaltarsi o gioire in maniera esagerata per una piccola fortuna può infastidirci: la sua felicità ci sembra sproporzionata perché non riusciamo a condividerla, e allora la giudichiamo frivola o irragionevole. Persino le reazioni più innocue, come ridere troppo a lungo a una battuta, possono farci sentire a disagio, perché misuriamo l’intensità delle emozioni altrui rispetto alla nostra.
Quando le emozioni di una persona coincidono con quelle che proviamo noi nel guardarla, ci sembrano giuste e appropriate: ci sentiamo in sintonia con ciò che prova. Al contrario, se le sue emozioni non corrispondono alle nostre, ci sembrano eccessive, insufficienti o fuori luogo. In pratica, approvare i sentimenti di un altro significa provare simpatia per essi; non approvarli significa non riuscire a condividerli.
Ad esempio, se qualcuno si arrabbia per un’offesa e noi proviamo la stessa indignazione, consideriamo la sua rabbia giustificata. Se qualcuno soffre e noi condividiamo la sua pena, la riteniamo ragionevole. Se ammiriamo la stessa poesia o lo stesso quadro nella stessa misura, riconosciamo che la sua ammirazione è corretta. E se ridiamo alla stessa battuta nello stesso modo, la nostra risata ci appare appropriata.
Al contrario, chi non prova sentimenti simili ai nostri tenderà inevitabilmente a giudicare i nostri come eccessivi o inadeguati. Se la nostra rabbia supera quella del nostro amico, se la nostra pena è più intensa della sua compassione, se la nostra ammirazione o la nostra risata non corrispondono alle sue, sarà inevitabile che egli consideri i nostri sentimenti sproporzionati. In sostanza, gli altri confrontano sempre le proprie emozioni con le nostre per giudicare se ciò che proviamo è giusto o sbagliato.
Ci sono situazioni in cui sembra che approviamo le emozioni degli altri senza condividerle davvero. Per esempio, possiamo riconoscere la giustezza di una risata collettiva a uno scherzo anche se, in quel momento, non ridiamo personalmente perché siamo distratti o di cattivo umore. In realtà, la nostra approvazione si basa comunque su una forma di simpatia: sappiamo dall’esperienza che in circostanze normali ci saremmo uniti alla risata, quindi riconosciamo che la reazione degli altri è naturale e appropriata.
La stessa dinamica vale per tutte le emozioni. Se incontriamo uno sconosciuto profondamente afflitto perché ha appena perso il padre, riconosciamo subito che il suo dolore è giustificato. Tuttavia, potremmo non provare immediatamente la stessa intensità di sofferenza, magari perché non conosciamo la persona o siamo distratti. Nonostante ciò, sappiamo dall’esperienza che situazioni simili suscitano naturalmente un grande dolore e, se ci prendessimo il tempo per riflettere, simpatizzeremmo sinceramente. È proprio questa consapevolezza di una simpatiapotenziale, basata su esperienze passate, che ci permette di approvare il suo dolore anche quando, in quel momento, non lo sentiamo pienamente.
Quindi come facciamo a giudicare la condotta di una persona? Quando giudichiamo se le emozioni altrui siano appropriate o eccessive rispetto alla situazione, ci basiamo quasi sempre sui nostri stessi sentimenti. Se, immaginandoci al loro posto, scopriamo che le emozioni coincidono con le nostre, le riteniamo giuste e proporzionate. Se invece non corrispondono ai nostri sentimenti, le giudichiamo esagerate o fuori luogo.
Ogni nostra facoltà diventa il metro con cui valutiamo quella degli altri. Usiamo la nostra vista per giudicare la vista altrui, il nostro udito per valutare il loro, la nostra ragione per misurare la loro, e lo stesso vale per i sentimenti: giudichiamo l’amore o il risentimento degli altri in base a come li viviamo noi. Non abbiamo, né possiamo avere, un altro criterio di confronto.
Anche se siamo naturalmente empatici, le emozioni degli altri raramente raggiungono l’intensità di chi le prova direttamente. La nostra simpatia si basa su un “scambio immaginario”: sappiamo che non siamo noi a soffrire, quindi il coinvolgimento emotivo resta più moderato. Chi prova dolore intenso desidera che gli altri condividano pienamente la sua sofferenza, ma può ottenere solo una forma attenuata di questa concordanza. Per armonizzarsi con gli altri, la persona coinvolta deve in qualche modo ridurre l’intensità delle proprie emozioni fino al livello che gli spettatori sono in grado di comprendere.
La società, però, permette questa corrispondenza. Così come gli altri cercano di mettersi nei panni di chi soffre, anche chi soffre impara a considerare le reazioni degli altri e a moderare i propri sentimenti di conseguenza. Questo equilibrio è più facile da ottenere in presenza di amici, un po’ meno con conoscenti e ancora meno con estranei. La consapevolezza di come gli altri osserveranno la nostra situazione ci aiuta a calmare le emozioni, favorendo una forma di tranquillità e controllo interiore.
In definitiva, la conversazione e la compagnia sono tra i rimedi più potenti per riportare equilibrio alla mente e mantenere un carattere sereno. Al contrario, chi vive in solitudine, pur potendo possedere grandi virtù morali, tende a essere meno equilibrato e meno capace di moderare le proprie emozioni.
L’uomo non desidera solo essere amato o lodato: desidera essere amabile e degno di lode, cioè un oggetto naturale e appropriato di affetto e approvazione, indipendentemente dal fatto che gli altri esprimano realmente questi sentimenti. Allo stesso modo, non teme solo l’odio o il biasimo, ma teme di esserne naturalmente degno.
Questo desiderio di essere amabili e degni di lode non nasce semplicemente dall’amore per l’elogio o dall’evitare il biasimo: è un impulso distinto. Quando ammiriamo e amiamo chi agisce con virtù, desideriamo diventare simili a loro, meritevoli dello stesso affetto e della stessa stima. Questa aspirazione all’eccellenza nasce dall’emulazione, dal desiderio di eccellere quanto coloro che ammiriamo.
Per provare vera soddisfazione, dobbiamo giudicare il nostro carattere e le nostre azioni con occhi imparziali, come farebbero gli altri. Quando il nostro giudizio coincide con quello che immaginiamo dagli altri, proviamo felicità e auto-approvazione. E quando gli altri confermano davvero questa valutazione attraverso la loro approvazione o lode, la nostra sensazione di essere degni si rafforza. In questo senso, il desiderio di essere degni di lode è primario, mentre l’amore per la lode deriva in gran parte da esso.
La lode è significativa solo se percepiamo di meritarla. Non ci dà vera soddisfazione essere ammirati per errori o per inganno: se sappiamo di non meritare la stima ricevuta, la lode ci sembra vuota o addirittura mortificante. La vera gioia nasce dal sapere di aver agito correttamente, indipendentemente dal fatto che gli altri ce ne rendano merito.
In altre parole, ciò che conta non è tanto essere lodati, quanto essere degni di lode. Anche senza ricevere approvazione esterna, possiamo provare soddisfazione riflettendo sul nostro comportamento secondo standard oggettivi o imparziali. L’auto-approvazione si fonda sulla consapevolezza di aver agito come ci si aspetta che chi merita lodi agirebbe. Questa convinzione ci permette di provare piacere e orgoglio, anche in assenza di riconoscimento esterno, come accade in casi estremi in cui le persone compiono grandi imprese con la certezza che il mondo non ne verrà a conoscenza.
L’uomo teme non solo di essere disprezzato, ma di esserlo giustamente. Anche se nessuno dovesse mai venire a conoscenza dei suoi crimini, chi agisce male prova orrore e rimorso per la propria condotta, anticipando il disprezzo naturale che susciterebbe negli altri. Questo principio spiega perché la coscienza e la sensibilità morale possano tormentare persino chi è certo di non essere scoperto, mentre i criminali incalliti spesso restano indifferenti.
L’ingiusta accusa di un crimine può infliggere un dolore molto più intenso della giusta lode o persino della punizione reale, soprattutto per chi è innocente. Anche le offese minori possono ferire profondamente le persone sensibili, mentre chi commette il vizio deliberatamente spesso non percepisce il disonore delle proprie azioni. In generale, l’accordo o il disaccordo tra il nostro giudizio e quello degli altri pesa su di noi in proporzione alla nostra certezza sulla correttezza dei nostri sentimenti. Quando siamo sicuri di aver agito bene, il giudizio altrui conta meno; quando dubitiamo, approvazione e disapprovazione diventano balsamo o veleno per la nostra mente.
La Teoria dei sentimenti morali di Adam Smith ci ricorda che la vita sociale e morale non nasce da freddi calcoli o da ragionamenti astratti, ma da un tessuto sottile di emozioni condivise. La simpatia ci permette di entrare nei sentimenti degli altri, di provare gioia e dolore insieme a loro, e di orientare le nostre azioni secondo ciò che consideriamo giusto e appropriato. Allo stesso tempo, il desiderio di essere amabili e degni di lode guida le nostre scelte morali, rendendoci attenti non solo a ciò che gli altri pensano di noi, ma soprattutto a ciò che effettivamente meritiamo.
In questo equilibrio tra auto-approvazione e giudizio altrui, tra piacere e dolore, tra emulazione e timore del biasimo, Smith individua il cuore della vita morale: la capacità di sentire, comprendere e valutare sia noi stessi sia gli altri. La sua riflessione ci invita a considerare la virtù non come un obbligo imposto dall’esterno, ma come un sentimento naturale che nasce dalla nostra empatia, dalla nostra sensibilità e dal desiderio di essere persone degne di affetto e rispetto. In definitiva, essere buoni e giusti non significa solo conformarsi alle aspettative altrui, ma coltivare dentro di sé la propria approvazione, costruendo una moralità che resiste anche all’indifferenza o all’ingiustizia del mondo esterno.
Questo articolo è utile per gli studi dei corsi di Filosofia Morale.

Studente di Storia
Ciao, sono Matteo Galavotti. Frequento il secondo anno di Storia presso l'Università di Bologna e ho fondato StudiaStoria.it per unire la mia formazione accademica alla passione per il web development. Programmo personalmente questo sito e ne curo i contenuti, trasformando il mio percorso di studi in articoli di divulgazione accessibili a tutti, con un occhio attento al rigore delle fonti e uno alle moderne tecnologie digitali.
Leggi tutti gli Articoli di Matteo GalavottiRicevi i nuovi articoli appena escono e spunti extra per il tuo ripasso.
Vai al Canale
![Copertina Guerre d'Italia (1494-1559): Riassunto, Schema e Mappa [+PDF]](/public/img/guerre-italia/battaglia-di-marignano-1515-350.jpg)


Come sei arrivato qui oggi?
Ci daresti un dettaglio in più?
(es. "link su Classroom" o "vorrei un articolo su...")